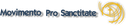Più che “narrare” padre Guglielmo, ci sembra assai più efficace lasciare la parola a lui che, già avanti negli anni, tornava volentieri ai primi passi della sua vocazione e del suo sacerdozio; consegnava così ai posteri gustosi aneddoti del suo vissuto, insieme a originali e profondi spunti di riflessione. Sono trafiletti di suo pugno, pubblicati nei primi anni Novanta dal periodico “Il massimalismo”, nella rubrica intitolata “Il sacerdote lo conosci tu?”, che ora di buon grado riproponiamo in questa sede, per allargarne la condivisione, per dilatarne la risonanza. Per riandare con gioia alle radici del carisma “pro sanctitate”.
La rubrica "Così si raccontava padre Guglielmo Giaquinta", è stata curata da Marialuisa Pugliese, Postulatrice della Causa di beatificazione del Servo di Dio.
La prima edizione della rubrica " così si raccontava Guglielmo Giaquinta", è stata pubblicata da e su "diteloatutti.net" nell'estate del 2017
Un Germoglio nel Prato

Lo guardi ammirato e ti chiedi: ma quel seme chi l’ha portato in questa zolla? Forse il volo di una farfalla o di un uccello o l’impeto del vento autunnale. Forse, ma non lo sai. Conosci tu come spunta la vocazione sacerdotale? E’ un mistero e ora voglio raccontarti il mio mistero.
Frequentavo con gioia la mia parrocchia, sul Casilino, e anzi ero anche esploratore. Ma di farmi prete non se ne parlava. Dovetti iscrivermi tra gli avanguardisti, e ogni volta che passavo davanti alla mia chiesa sentivo uno struggimento nell’anima. Ma di farmi prete neppure l’ombra.
Imparai a marinare la scuola e santificavo l’assenza raccogliendo francobolli vecchi per le missioni. Ma di farmi prete non se ne parlava. La marachella urtò mio padre, il quale decise di mettermi a scuola dai preti. Cosa strana: nell’istante in cui io varcai la soglia di quella scuola ebbi la certezza che dovevo diventare prete. Certezza che non è più svanita.
Da dove quel seme spuntato solitario in un prato non coltivato? È il mistero di Dio che noi dobbiamo solo ammirare senza pretendere di poterlo spiegare. È la vocazione sacerdotale.
Guglielmo Giaquinta da - “Il Massimalismo”, n. 9, febbraio 1989


La panchina
Il vento, in genere, scuote ma non calpesta il germoglio del prato; questo invece può farlo chi vi passa sopra con piede incauto. Credi tu che la vita di un giovane che arrivi al sacerdozio sia priva di ostacoli e di difficoltà?
Entrare in seminario era troppo arduo per le finanze della mia famiglia e iniziai così il semiconvitto. Il che significava alzarmi prestissimo e poi raggiungere le scuole presso S. Pietro. Al ritorno prendevo il tram 36 che mi lasciava a Porta Maggiore dove salivo sulle “vicinali” (o andavo a piedi) per raggiungere la mia casa.
Una sera, sceso dal tram, mi misi a sedere su una panchina di pietra, con la mia borsa di scolaro. Perché? Non lo ricordo più. Mi si avvicinò un anziano sacerdote e si mise a sedere accanto a me, chiedendomi gentilmente chi fossi e che facessi. Gli raccontai, gioioso, la mia storia ed egli mi ascoltò in silenzio.
Poi iniziò lui: ma lo sai cosa devono fare i preti? Devono ubbidire al Vescovo e perfino cambiargli le scarpe durante la Messa. Aggiunse ancora altre cose che non ricordo, ma che mi impressionarono. Arrivai a casa stravolto. Papà se ne accorse e quando seppe dell’accaduto voleva andare a Porta Maggiore. Ma quel prete, dove trovarlo più?
Rimasi con il mio turbamento e con l’immagine delle scarpe del Vescovo da cambiare. Solo in seguito seppi che si trattava di un innocuo rito liturgico, ormai scomparso. Il tempo, capace di levigare tutto, attutì la dolorosa impressione e addolcì la mia tempesta interiore.
Quel prete incauto avrebbe potuto schiacciare il tenero germoglio e fu grazia di Dio se questo non avvenne. Ma questa, e le tante altre difficoltà dello sviluppo di una vocazione, chi le conosce se non chi le sperimenta?
da “Il Massimalismo”, n. 9, febbraio 1989
GLI "EUNUCHI" DI DIO; Appunto di un seminarista alla vigilia di emettere la promessa di celibato

Gli Apostoli rimasero stupiti e interdetti quando Gesù parlò della legge della indissolubilità matrimoniale. Allora è meglio non sposare! Ma chi può affrontare il rischio di una solitudine assoluta: senza una compagna, né dei figli propri? Chi può rinunciare ad un focolare e alla gioia della intimità domestica?
Gli apostoli non si posero il problema, ma Gesù volle risolverlo ugualmente. Ci sono delle creature – ed Egli li chiama “gli eunuchi per il regno dei cieli” – che hanno da Dio la chiamata e la grazia di affrontare un tale sacrificio con i rischi conseguenti.
Sacrificio: ma fatto per amore, con la prospettiva di avere una più grande famiglia spirituale di figli generati nel sangue di Cristo. Rischio: perché nessuno è invulnerabile e solo la grazia di Dio, ottenuta dalla preghiera e dalla mortificazione, può dare la morale sicurezza del dominio delle innate tendenze naturali.
Ma è proprio questo che Tu vuoi da me, Signore? Io sento che tu me lo chiedi e nulla io voglio rifiutarti. Ma stammi tu accanto, Signore, lungo tutti i passi della mia vita.
da “Il Massimalismo”, n. 12, luglio-agosto 1989
Mia madre

Ho ancora nella memoria il racconto delle tante “trovature” di tesori sepolti che la mia mamma mi faceva. E lei, sulla verità di quei presunti fatti, ci avrebbe giurato. Non solo di questo parlava. A volte sentivo racconti, non certo edificanti, del prete X e del canonico Z. E anche su questo essa avrebbe giurato.
Povera mamma mia, cosa sapeva lei del vero volto del prete? E comprendo, così, perché fosse per lei inconcepibile che proprio uno dei suoi figli volesse prendere la strada del sacerdozio. Il prete non lo conosceva ancora.
Ho ricevuto, in questi giorni, dall’America, un libro dal titolo suggestivo rivolto al Papa: Schiavitù e pace. Vi si parla di tante cose, soprattutto della Madonna di Fatima, e si deplora una certa opposizione, nelle alte sfere, tra il Papa e un Cardinale da una parte e un altro Cardinale, collaboratore del Papa, dall’altra.
Speriamo che siano pochi a leggere il libro. E questo perché esso non serve a far conoscere veramente di più il prete. Ma quanti, in realtà, lo conoscono non solo nei suoi aspetti minori, ma anche nei suoi grandi problemi e, tanto più, nella sua vera grandezza?
da “Il Massimalismo”, n. 9, febbraio 1989
Il volto sorridente del prete novello

Era il 17 marzo sera e avevamo appena terminato gli esercizi in preparazione all’Ordinazione sacerdotale. Di stanchezza ce n’era più che a sufficienza, e da qui il desiderio e la speranza di un sonno ristoratore. Avevo però il cervello troppo lucido e un cuore in attesa del grande momento.
Mi misi a letto, ma di dormire non se ne parlava. Mezzanotte, l’una, le due, e cominciai a sentirmi male. Il cuore aveva degli strani sussulti, che solo poi seppi essere delle extrasistole.
Ma che mi succede, pensavo; vorrà forse il Signore negarmi la gioia del sacerdozio e chiamarmi a sé proprio questa notte? Un senso di angoscia mi attanagliava, mentre l’invocazione alla Madonna della Fiducia sgorgava più frequente dal mio cuore.

Le tre, le quattro: e solo allora caddi sfinito in un sonno brevissimo, giacché la nostra sveglia suonava inesorabile alle 5.30. Mi alzai e mi sistemai, felice che ormai avevo superato il pericolo temuto e potevo diventare sacerdote.
Se hai la fortuna di assistere ad una Ordinazione sacerdotale, ricorda che sotto il volto sorridente del giovane sacerdote c’è tutta la realtà di una creatura che, nell’attesa della gioia, è stata trasformata nel Cristo del Getsemani e del Golgota.
da“Il Massimalismo”,
n. 15, gennaio-febbraio 1990
Il valore di un'amicizia

Un amico è come l’aria: la usi, ne godi, ma ne avverti l’importanza solo quando ti viene a mancare. Ho compreso questo soprattutto nel caso di don Teodoro. Più grande di me di parecchi anni, uomo ecclesialmente affermato dinanzi a me ancora giovane e immerso nei miei studi di diritto, pieno di esperienza pastorale ma di una estrema semplicità, ha inciso profondamente nella mia vita apostolica.
Venuto come un piccolo implume nella parrocchia della Madonna dei Monti, trovai nella vicinanza di don Teodoro la mia più profonda vocazione di confessore e direttore spirituale.
Abitava a Monteverde ed era impiegato presso la Sacra Congregazione per i Sacramenti. Eppure ogni mattina, prima di andare in ufficio, veniva nella nostra parrocchia, celebrava la Santa Messa e poi, diritto in confessionale, pronto a scappare via dopo un’oretta per giungere in tempo al suo tavolo di lavoro.
Lo rivedevo, poi, ogni mercoledì e ogni sabato dalle 16 alle 21 e la domenica mattina dalle 8 alle 12, sempre seduto in confessionale. Se lo faceva lui, perché non avrei potuto farlo anch’io? E fu così che ebbe inizio il mio apostolato nel confessionale che, nella mia vita, ha avuto una parte preponderante.

Un giorno però, e don Teodoro era ancora relativamente giovane, mentre si trovava in sacrestia, avvertì un dolore lancinante al petto e stramazzò per terra. Portato subito all’ospedale, i medici riscontrarono un infarto grave che, dopo non molto, lo portò all’eternità. Avevo trovato un protettore in cielo, ma in terra avevo perduto un amico.
Parlavamo a lungo insieme, ci scambiavamo le idee; era dolce e rasserenante passeggiare lentamente la domenica, dopo pranzo, lungo Via dei Fori Imperiali. Ormai era tutto finito e quell’amico io al mio fianco non l’avevo più. Ma quei ricordi e la dolcezza dell’amicizia non li ho mai dimenticati.
Quanto è bello per un sacerdote avere un amico, o anche più, con cui condividere serenamente tutti i problemi della propria vita. Tempo sprecato? No. Purtroppo spesso ci lasciamo schiacciare dal troppo lavoro rimanendo, stanchi ed isolati, nella illusione di aver fatto tante cose, senza avvertire il nostro graduale impoverimento interiore.
Come mai questo? Forse noi preti, e non solo i preti, non siamo stati abituati al valore di una sana e corroborante amicizia. Non c’è dubbio che anche per noi vale il vecchio proverbio: “Chi trova un amico trova un tesoro” (Sir 6, 14).
da “Il Massimalismo”, n. 23, maggio-giugno 1991
Nel confessionale con la carità

Si è oggi tentati di pensare, dopo certi incontri con alcuni sacerdoti, alle confessioni a gettoniera, quando poi non succede di peggio, per esempio: Da quanto tempo si è confessato? Da quindici giorni. Ma allora perché torna così presto? Basta un atto di dolore!
Scena questa non ipotetica, che sottende una certa concezione infiltratasi tra alcuni membri della Chiesa dopo il Vaticano II.
E mi ricorda, questo, l’emozione e la paura nel dare le prime assoluzioni. Per la gente il confessare può apparire come una cosa semplice e normale. E così non è. Appena qualche episodio che fa comprendere la drammaticità che, non di rado, accompagna il rimanere in confessionale.
Ordinato sacerdote a marzo, per S. Giuseppe, nella festa di Pentecoste fui mandato al Divino Amore ad ascoltare le confessioni delle migliaia di persone accorse al Santuario e, malgrado fossimo molti sacerdoti, mi trovai dinanzi a una coda di gente che non finiva più. Che pena dover dare l’assoluzione in fretta, con il rimorso continuo di una non completezza dell’esame!
In altra occasione volli essere più preciso. Abbondavo, per scrupolo interiore, nelle domande, quando sentii bussare alla porta della stanzetta dove confessavo gli uomini. Un sacerdote, gentilmente, mi pregò di passare alla confessione dei piccoli giacché la coda degli uomini che aspettava fuori della porta aumentava sempre più!
E che dire poi della pena e anche delle notti insonni nel ripensare a fatti gravi ascoltati in confessione? No, non è semplice confessare. E se questo si fa con spirito di carità soprannaturale comporta un coinvolgimento totale di anima e corpo che è partecipazione alla donazione immolativa di Cristo.
da “Il Massimalismo”, n. 16, marzo-aprile 1990
Un ricordo... e la certezza delle radici

Sono nato in una cittadina della Sicilia, a Noto, 75 anni fa, e sono venuto a Roma quando ero ancora bambino: avevo dieci anni; dopo qualche anno sono entrato in Seminario.
Mi sono sentito talmente romano (facevo anche le poesie in romanesco), che gustavo la gioia di non essere più tornato in Sicilia; fatto strano, direi superbia infantile o giovanile! E’ durata fino al 1950 questa mia “romanità”, per cui non avevo più avuto contatti con la Sicilia; poi, nel ’51 mi sembra, sono dovuto tornarvi per una causa matrimoniale (a quel tempo ero ufficiale del Tribunale matrimoniale del Vicariato).
Avevo da poco iniziato il lavoro delle Oblate e del Movimento e lì ebbi occasione di parlarne, e allora la mia integrità, la mia purezza romana fu un po’ scalfita. Ma interiormente mi sentivo ancora romano, e fino all’89 – anche se per circostanze varie sono tornato un paio di volte nella mia cittadina natia, a Noto – me ne sentivo estraneo, senza una particolare attrazione.
Un fatto nuovo, per me inspiegabile, è avvenuto l’8 maggio di quest’anno. Sono tornato, dopo 7 o 8 anni, a Catania, e lì ho sentito il bisogno, il desiderio di rivedere la mia cittadina; non mi era mai successo, e così sono andato a Noto. Ho visto parecchie cose: ricordavo poco, molto mi è tornato alla mente; e lì è avvenuto qualcosa di particolare. Ho capito il significato del mio compleanno e del mio onomastico, che rappresentano due momenti coessenziali dell’amore di Dio.
Tornare lì è stato per me avere l’esperienza di questo duplice dono naturale e soprannaturale di Dio, per cui ho sentito che quel 25 giugno di 75 anni fa, come di ogni anno della mia vita, doveva essere la giornata del ringraziamento. Piccolo particolare: quando si pensa all’onomastico si pensa al santo, non si riflette che il nome del santo viene dato nel giorno in cui si riceve il battesimo; non si riflette che è una doppia festa, quella della nascita naturale e della nascita soprannaturale.
Non posso non ringraziare il Signore per il fatto che dall’eternità mi ha voluto come sua creatura, con il dono naturale della vita che mi ha schiuso alla meravigliosa relazione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito. Da quel momento, in quell’ambiente – perché là sono nato, là sono stato battezzato – su una realtà puramente naturale si è impresso il sigillo della Trinità, per cui oggi posso dire, rispondendo alla domanda di Gesù ai suoi apostoli: “Chi dicono che io sia?” (e quello che io dico per me evidentemente vale per ciascuno di noi, per tutti): io sono un segnato dall’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Qui, oltre alla gioia che nasce da questa visione cristiana, dalla scoperta del mio essere, nasce una riflessione responsabile, di questo progetto di Dio. E allora è logico che, nel giorno di ringraziamento, io elevi la mia preghiera al Signore.
Grazie Signore per il mio compleanno, perché mi hai voluto alla vita, perché mi hai voluto lungo tutti questi anni, momento dopo momento, per attuare anche umanamente il tuo progetto. Grazie soprattutto per i doni soprannaturali, per il dono dell’amore al Padre, per il dono di essere il dispensatore dello Spirito. Signore, Dio della dolcezza, nel tuo giudizio verso di me e verso tutti, sii dolce e mite e donaci la forza di saper corrispondere al dono degli anni e al dono della grazia.
Da “Il Massimalismo”, n. 13, settembre-ottobre 198

Quanti libri!

Guardavo, passeggiando lungo la stanza, i vecchi libri sistemati con cura nei numerosi scaffali. Quanti ricordi, quanta nostalgia. Anni passati che mi sembrano ieri, che però sono ormai troppo lontani.
Sono anziano, sono malato e non posso più leggere e studiare. Mi rimane solo qualche stralcio di tempo in cui scribacchiare qualche riga. Da qui il senso di pungente nostalgia, assieme ai tanti ricordi.
I lunghi anni trascorsi in Seminario, con gli studi fatti e i molti libri letti e le lingue più varie apprese: mi danno ora il senso del vano e la sofferenza di non più avere ciò che pur tanto è stato amato.
Anni di studio. Dai cinque del ginnasio, ai tre del liceo, ai due di filosofia, ai cinque di teologia, ai quattro del Diritto Canonico e Civile … Quanto tempo! che mi sembrò, in un momento della vita, senza significato, giacché il dover insegnare catechismo ai bambini era cosa assai diversa. Eppure continuavo. Volevo, pensavo e studiavo senza stancarmi, immergendomi nello studio delle lingue antiche e moderne e nell’approfondimento della spiritualità.
Sarà valso tutto questo a qualche cosa? Spero di si. Adesso però una certezza in me si è creata: la parola del Maestro vale più di tutti i libri accumulati nel mio povero cervello. Ed è quanto ancora oggi, anziano e malato, posso fare: mettermi con Maria ai piedi del Maestro e ascoltare la sua parola. Io so che anche a me Egli ripete che finalmente oggi ho scoperto la parte migliore.
da “Il Massimalismo”, n. 11, giugno 1989
Storia di una vocazione

Sognavo, da bimbo, imprese più grandi di me che mi portavano nel regno fatato di regine, imperatori e pirati. Più tardi fu l’impresa di Teresa la grande, che fuggì per convertire i Mori, che mi attrasse. Più tardi ancora l’esempio della piccola carmelitana di Lisieux avvinse il mio animo giovanile: soffrire come lei, offrire come lei, per potere, come lei, morire in un’ estasi di amore per la salvezza delle anime.
Morire giovane, morire vittima, offrire la propria vita a tale scopo: mi sembravano le mete luminose verso le quali dovevo indirizzare i miei sforzi. E il flebile lamento di Gesù agonizzante sulla croce risuonava al mio animo come l’invito ad offrirmi generosamente vittima per i fratelli.
Gli anni passarono e i sogni sfiorirono. Morire giovane non era più possibile e offrirsi vittima alla divina giustizia rimaneva come ideale altissimo ma sproporzionato alla viltà che si era sviluppata, connaturata al mio carattere. Ripiegare dunque su una posizione di mediocrità e contentarsi di camminare costa costa, senza azzardarsi a tentare le scalate delle vette luminose, ma troppo ripide?
Fu l’amore redentivo che dette la soluzione definitiva alla mia anima. L’analisi dei sentimenti del Cuore di Cristo mi portò al centro della sua anima e lì trovai che in Lui, Verbo Incarnato, tutto era in funzione della salvezza delle anime. Per esse Egli si era incarnato ed aveva vissuto lunghi anni nel nascondimento di Nazareth; per esse si era stancato lungo i sentieri montani o pianeggianti della Palestina ed aveva predicato, moltiplicato miracoli, passato notti insonni; per esse era morto sul duro legno della Croce ed era infine risorto.
L’amore per le anime era dunque il centro dei misteri interiori della vita di Gesù. Con il Sacerdozio Egli mi aveva dato di partecipare a tali misteri creando in me la passione per la redenzione delle anime; amore redentivo in Gesù, corredentivo in me.
Una certezza allora sentii svilupparsi interiormente: io ero e dovevo essere solo per le anime. Anche la santità, l’acquisto delle virtù, mi sembrava che non potessero in me avere un significato completo se avessi voluto prescindere dalle anime. Dovevo anzi santificarmi per loro come Gesù aveva rivelato di se stesso: “Sanctifico me ipsum ut et ispi sint sanctificati” (Gv 17,19).
Non si trattava più della passione per le anime ma di un orientamento nuovo; l’amore redentivo era divenuto il centro della mia spiritualità. Il “Sitio” di Cristo era anche espressione di indicibile sofferenza, ma era soprattutto desiderio infinito di anime. Le anime dunque io dovevo cercare, trovare, amare; per esse dovevo stancarmi e, se necessario, morire. Ma non la morte o la stanchezza o la sofferenza avevano significato per me, ma le anime comprate con questi mezzi.
Era stato dunque solo un sogno di ingenua giovinezza quel mio attendere una morte prematura in un’offerta che mi avrebbe consacrato vittima. Gesù certo era morto vittima, ma dopo aver lavorato e pregato e insegnato. E così per me. Solo che, mentre Gesù poteva disporre liberamente di se stesso alla luce della volontà del Padre, io non dovevo disporre di me.
Mi tornano alla mente insistenti i gradi dell’indifferenza ignaziana: la vita o la morte, la salute o la malattia, la ricchezza o la povertà, tutto è per me indifferente. Ma non precisamente di questo si trattava. Non era il distacco per il distacco, l’indifferenza per l’indifferenza, sia pure ispirata dal più alto amor di Dio. L’indifferenza per me nasceva dalla piena disponibilità all’azione redentiva di Gesù.
Egli continua a salvare le anime e cerca gli strumenti; richiede la mia libera collaborazione, la mia strumentalità. Io gliela dono incontrastata e lascio, anzi voglio, che Egli usi di me come più gli piace. Se vorrà farmi partecipe soprattutto della sua vita attiva, consumerò le mie forze per i fratelli; e se invece vorrà introdurmi nei misteri del silenzio di Nazareth, per essi ancora accetterò gioiosamente il mio scomparire. Mi sforzerò di salire sulla Croce, se il Signore mi chiamasse ai misteri della passione, e accetterò la momentanea esaltazione, se questo il Signore mi preparasse. Ma sempre per le anime, giacché io devo muovermi solo nella linea della corredenzione e il mio sacerdozio deve essere essenzialmente corredentivo.
PREGHIERA
Non ti chiederò dunque, o dolce Gesù Redentore, una lunga vita o una brillante intelligenza; non ti supplicherò perché accresca le mie energie o mi consumi sull’altare della sofferenza, vittima di amore e di giustizia. Nulla, o Redentore delle anime, io ti domanderò, ma solo di accettare il mio intenso desiderio di disponibilità all’opera redentiva, la mia consacrazione all’amore redentivo. Ogni altra mia domanda sarebbe superflua e forse limitativa dei tuoi piani redentivi. Tu sai ciò di cui hai bisogno e io voglio solo ripeterti con S. Agostino: “Dona quod iubes et iube quod vis” (Dona quanto comandi e comanda quello che vuoi).
Non dimenticare però, Signore, che anche il vivere questa consacrazione è tuo dono che a Te domando; come è tuo dono la moltiplicazione delle anime che comprendano e vivano tale consacrazione all’amore redentivo. Moltiplica tu tali anime tra i sacerdoti e le tue mistiche spose, nel popolo e tra i militanti dell’apostolato cattolico. Insegnalo Tu, a me e a tutti, che la tua sete di anime è sempre attuale e che l’opera redentiva ha ancora bisogno di anime generose. Amen.
da “Il Massimalismo”, n.44, novembre-dicembre 1994
riportato da G. Giaquinta, Suscipe hanc oblationem. Il dono di una giovinezza,
ed. Ancora, 1964, pag.156 ss.